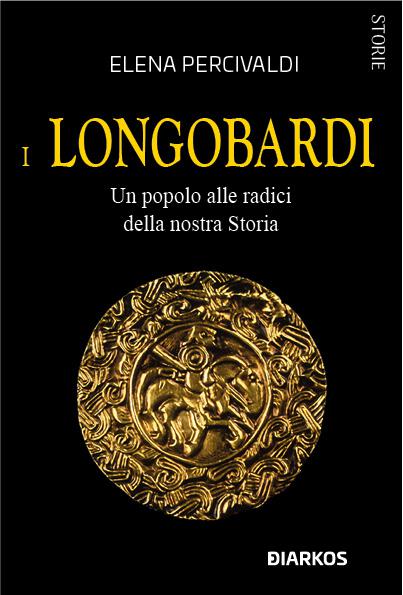"I Longobardi" di Elena Percivaldi su «Studi Medievali», serie terza, anno LXII - Fasc. I (2021).
25 Giugno 2021
Elena Percivaldi, Longobardi. Un popolo alle radici della nostra storia,
Santarcangelo di Romagna (RN), Diarkos, 2020, pp. 294 (Storie).
Il libro che non c’era: possiamo definire così la fatica appena approdata alle
stampe di Elena Percivaldi, anche se ciò, a prima vista, può sembrare strano.
Negli ultimi anni, infatti, è stata prodotta un’immensa mole di studi sui
Longobardi (fra cui, nel corso del decennio appena concluso, i cataloghi di
ben tre mostre1) e, oltre a quelli specialistici – per i quali sarebbe impossibile
perfino provare a stilare un elenco – è apparsa anche una serie di opere di sintesi
stampate in collane editoriali “economiche”, che hanno permesso anche a
lettori non specialisti di avvicinarsi all’argomento. Agli “apripista” rappresentati
dai lavori di Jörg Jarnut (1982, ma tradotto in italiano nel 1995) e Alessandra
Melucco Vaccaro (1982, la prima sintesi “popolare” sull’archeologia longobarda),
sono seguiti diversi altri prodotti, in genere di ottima qualità; in alcuni casi essi
1. I Longobardi. Dalla caduta dell’Impero all’alba dell’Italia, a cura di G. P. Brogiolo, A.
Chavarria Arnau, Milano, 2007; I Longobardi del Sud, a cura di G. Roma, Roma, 2010; I
Longobardi. Un popolo che cambia la storia, a cura di G. P. Brogiolo, F. Marazzi, C. Giostra,
Milano, 2017. A questi tre eventi di portata nazionale – o comunque sovraregionale – se ne
dovrebbero aggiungere altri di portata più locale, ma non per questo meno importanti, come
ad esempio ‘Petala aurea’. Lamine di ambito bizantino e longobardo dalla collezione Rovati, a cura
di M. Sannazzaro, C. Giostra, Monza, 2011.
recensioni 349
sono stati opera di studiosi, come Stefano Gasparri e Claudio Azzara che sono
stati fra i protagonisti – in Italia e non solo – del rinnovato dibattito sulla storia
di questo popolo e, più in generale, sulla transizione al Medioevo. In altri casi,
come in quelli delle opere pubblicate da Tommaso Indelli e da Nicola Bergamo,
si è trattato di lavori dovuti a studiosi più giovani che, forse con un pizzico di
incoscienza in più, si sono cimentati (peraltro con risultati assolutamente rispettabili)
nell’arduo compito della sintesi su un tema così frastagliato2.
Questo elenco non pretende di aver esaurito tutti i titoli di opere divulgative
sui Longobardi disponibili, ma certamente nomina quelle più accessibili attraverso
i normali canali di vendita.
Tutto ciò considerato, sotto quali aspetti il lavoro di Elena Percivaldi può
aggiungere qualcosa di nuovo a tale già variegato panorama? Io credo che i
suoi aspetti caratterizzanti in tal senso siano due: il primo è che l’Autrice (al
contrario di tutti gli studiosi precedentemente citati) non è un’accademica bensì
una giornalista attiva nella divulgazione storico-archeologica, e il secondo è che
la sua sintesi fa equanimemente uso di dati provenienti sia da fonti scritte, sia
archeologiche.
Perché il fatto che Elena Percivaldi non appartiene al mondo accademico
dovrebbe essere considerato in questa circostanza un elemento dotato di connotati
positivi? In genere, nelle discipline storico-archeologiche, la competenza
scientifica si forma all’interno del mondo accademico (o in quello dei ranghi
tecnico-scientifici del MIBACT) e non sarò certo io, che del mondo universitario
faccio parte, a contraddire tale assunto. Però ci sono delle eccezioni a questa
regola, ed il percorso di Elena Percivaldi può sicuramente essere annoverato fra
esse.
Innanzitutto, ella ha ricevuto una formazione medievistica a livello universitario
e poi, nella sua intensa attività di giornalista e divulgatrice, ha intensamente
lavorato su tematiche di ambito medievistico su testate accreditate a livello nazionale
e internazionale. Inoltre, ha sistematicamente collaborato con molti dei
principali gruppi italiani di historical renactment che, in questi ultimi anni, hanno
condotto, con grande rigore filologico, operazioni di recupero – a fini rievocativi
– di costumi, oggetti e perfino edifici appartenenti alla civiltà dei Longobardi.
Dunque, Elena Percivaldi è arrivata alla scrittura di questo libro dopo una lunga
frequentazione di tematiche altomedievali – e longobarde in particolare –, il che
le ha permesso anche di entrare personalmente in dialogo con molti studiosi
attivi in Italia su questi argomenti. Dando quindi per acquisito che ella sia una
persona sufficientemente preparata per trattare l’argomento ed una scrittrice
dotata di una bella capacità narrativa (il che non guasta mai in un libro…),
l’aspetto positivo, in questa specifica circostanza, della sua estraneità al mondo
2. J. Jarnut, Storia dei Longobardi, Torino, 1995 (ma ed. orig. tedesca 1982); A. Melucco
Vaccaro, I Longobardi in Italia, Milano, 1982; C. Azzara, I Longobardi, Bologna, 2015; Id.,
Andare per l’Italia longobarda, Bologna, 2019; N. Bergamo, I Longobardi. Dalle origini alla caduta
del regno d’Italia, Gorizia, 2012; S. Gasparri, Italia longobarda. Il regno, i Franchi, il papato, Roma-
Bari, 2012; T. Indelli, Langobardia. I Longobardi in Italia, Padova, 2013.
350 recensioni
universitario però è un altro. Il punto è che i diversi temi legati all’identità ed
alla cultura dei Longobardi ed al ruolo da essi avuto nella storia d’Italia sono stati
fra i più animatamente dibattuti nella comunità accademica del nostro Paese,
suscitando una vis polemica che normalmente si riserva ad argomenti cronologicamente
molto più vicini nel tempo. In realtà, il dibattito sui Longobardi fa
parte di una più ampia discussione che, a livello europeo, si è accesa in merito
all’epoca di transizione fra Antichità e Medioevo e, più in particolare, all’interazione
fra Romani e “barbari” a seguito dei grandi movimenti migratori verso
Occidente che avvennero a più riprese fra III e VI secolo sul suolo europeo.
Anche in passato ai Longobardi era toccato essere protagonisti, loro malgrado,
di discussioni molto accese che prendevano spunto dal passato per calarsi poi
profondamente nel presente: accadde nel XIX secolo, durante il Risorgimento,
quando il tema “caldo” era quello dell’Unità Nazionale. In quella temperie essi
furono giudicati, da alcuni studiosi, come la causa della rottura di tale unità definitivamente
raggiunta nel I secolo a.C. grazie alle conquiste dei Romani e, in
quest’ottica, come i primi “tedeschi invasori” del suolo italiano, capofila di una
lunga serie si che sarebbe conclusa con gli Austriaci di Cecco Beppe e Radetzky.
In alternativa, essi vennero invece considerati come un innesto provvidenziale
di forze fresche sul corpo ormai esangue della Romanità (rappresentata ormai
dalla corrotta Bisanzio), che avrebbe potuto ricostruire l’unità spezzata della
Penisola, se solo a tale progetto non si fosse opposto il papato che, chiamando
infine i Franchi, avrebbe avviato la sequela delle secolari soggezioni dell’Italia
a potenze europee straniere (ogni riferimento a Pio IX e ai suoi rapporti con
Napoleone III è puramente casuale). Di questo dibattito Elena Percivaldi dà
peraltro precisamente conto nel capitolo conclusivo del libro, a cui si rimanda
chi fosse curioso di approfondire.
Inutile nasconderselo, anche nel dibattito presente la discussione parla sì del
passato, ma con un occhio ben rivolto verso il presente.
Le riletture che hanno prevalso sul tema, a partire dagli ultimi due decenni
del XX secolo, sono state volte a smontare l’idea tradizionale che le migrazioni
dei “barbari” all’interno dell’Impero Romano abbiano portato solo sfacelo e
decadenza e siano avvenute all’insegna del conflitto fra identità “forti”. Molti
studiosi di grande calibro intellettuale (e accademico, non dimentichiamo…) si
sono gettati senza riserva nell’impresa di dimostrare che i popoli barbari – spesso
a partire dallo stesso nome che li ha designati – sono stati entità sorte al momento
dell’impatto con l’Impero, che si sono fittiziamente intestate – tramite
le proprie élites militari, che avevano bisogno di legittimarsi agli occhi dei loro
popoli – pedigree di antichità storica inesistenti, magari enfatizzati dalla storiografia
romana tardoantica che, a sua volta, doveva “costruire il nemico ideale”
per alimentare la propaganda imperiale. In realtà, secondo questa lettura, le genti
che componevano tali popoli avrebbero avuto alle spalle una storia di continua
ridefinizione della loro identità e della loro organizzazione politica, oltretutto
vivendo buona parte del loro recente passato in un rapporto di forte prossimità
– se non di simbiosi – con l’Impero, e quindi di forti scambi economici e culturali
con esso. Non avendo quindi avuto modo di sviluppare un’identità forte
recensioni 351
alternativa a quella romana e scevra dai suoi influssi, non avrebbero avuto neppure
motivo per cui essa avrebbe dovuto necessariamente proporsi in maniera
conflittuale rispetto ad essa. Ma poi, esisteva un’identità romana? In realtà, anche
l’Impero era formato da un crogiuolo di popoli su cui quelli italici avevano da
tempo perduto l’egemonia, in profonda trasformazione nel corso dei secoli.
Come, dunque, avrebbe potuto prodursi un cozzo violento fra soggetti così
plastici e – come si usa dire ora – resilienti? E così, al concetto di “declino
e caduta” si è affiancato quello di “trasformazione” dell’Impero Romano; alla
definizione tradizionale degli stati post-romani come “regni romano-barbarici”
si è giustapposta quella di “Kingdoms of the Empire”; e a quella di “invasioni
barbariche” si è voluta preferire la più neutra di “migration period”. Lo storico
tornante fra Antichità e Medioevo – elaborato dalla cultura umanistica del XV e
XVI secolo – si stemperava in una lunga “Tarda Antichità” in cui i nuovi venuti
– almeno nei territori occidentali – si erano progressivamente impadroniti delle
province imperiali e vi si erano insediati in via permanente «in a natural, organic
and generally eirenic manner»3.
Il risultato di tutto ciò fu che «one of the most significant transformations of
the Roman world in Late Antiquity was the integration of barbarian people into
the social, cultural, religious, and political milieu of the Mediterranean world»4.
Da questa visione, maturata principalmente all’interno del mondo degli studiosi
delle fonti scritte, è discesa una serie di incursioni nel mondo dell’archeologia,
che hanno da un lato “decostruito” la convinzione che i materiali di
corredo funerario rinvenuti nelle sepolture di quelli che sono considerati gli
esponenti di maggior rilievo dei popoli invasori potessero essere considerati
come “marker” di una cultura tradizionale propria del popolo cui essi appartenevano
e, dall’altro, hanno messo in dubbio che le persone adornate di quegli
oggetti dovessero necessariamente essere solo dei “barbari” e non potessero essere
piuttosto anche dei Romani cooptati nei ranghi dei nuovi venuti. D’altra
parte – si è argomentato – se molti “barbari” avevano da tempo iniziato a militare
nelle armate romane, come si può escludere che fosse avvenuto anche il
contrario?
È evidente – come si diceva in precedenza – che questi sforzi di radicale
revisione dei tradizionali paradigmi interpretativi sulla fine dell’Antichità parlassero
al passato guardando al presente (o essendone fortemente ispirati, che in
fin dei conti è lo stesso), almeno tanto quanto i precedenti, che contrapponevano
“graniticamente” la romanitas ai popoli del barbaricum, potevano averlo fatto
3. Society and Culture in Late Antique Gaul: Revisiting the Sources, edited by R. W. Mathisen,
D. Shanzer, Aldershot, 2001, pp. 1- 2. Le citazioni di asserzioni di analoga natura potrebbero
essere moltissime (e un’altra di analogo tenore la riporto nella nota seguente), ma questa,
selezionata da B. Ward-Perkins, mi sembra assolutamente emblematica (B. Ward-Perkins, The
Fall of Rome and the End of Civilization, Oxford, 2005, p. 10).
4. Romans, Barbarians, and the Transformation of the Roman World: Cultural Interaction and
the Creation of Identity in Late Antiquity, edited by R. W. Mathisen, D. Shanzer, Farnham-
Burlington, 2011, p. 1.
352 recensioni
ispirandosi alle competizioni nazionaliste europee del XIX e della prima metà
del XX secolo.
In altre parole, affievolire i contrasti fra barbari invasori (o migranti, che
dir si voglia) e romani invasi (o, alternativamente, accoglienti) significa inviare
un messaggio ben preciso riguardo i contrasti che molte società occidentali
vivono nel presente, vuoi per la complessa attuazione del melting pot all’interno
di una società da sempre assai composita (gli USA), vuoi per le tensioni
innescate in nazioni più “tradizionali”, ma anche ex potenze colonialiste (vedi
la Francia e l’Inghilterra), dalla massiccia immigrazione di gruppi di provenienza
asiatica e africana: se l’Impero romano si è solo “trasformato”, ma non
è drammaticamente collassato in seguito ai massicci fenomeni migratori della
Tarda Antichità, una speranza c’è anche per noi oggi che il futuro non riservi
analoghe sorprese...
Infine, c’è una fonte parzialmente diversa del revisionismo storiografico
sulle grandi migrazioni, ed è quella che è sgorgata all’interno del mondo
austro-tedesco. Dopo i traumi prodotti dalla Seconda Guerra Mondiale e dai
sogni di egemonia continentale tedesca risalenti già al XIX secolo, era diventata
un po’ complicata da gestire l’idea di una “civiltà germanica” destinata
prima a rimpiazzare l’ormai esangue e corrotto mondo romano, e poi a
resuscitarne i migliori valori giuridico-amministrativi e ad imporsi infine su
tutto il continente europeo. In effetti, già il progetto dei Monumenta Germaniae
Historica preconizzava l’idea di una germanitas disseminata su tutta l’Europa
attraverso la volkerwanderung tardoantica (e quindi quella di una storia dell’Europa
post-antica interamente germanizzata), ma sarebbe stata la ricerca archeologica
a fornire nuovo carburante a tutto ciò, identificando – a partire dalla
fine dell’800 – le tracce materiali della presenza dei nuovi venuti all’interno
dei territori ex-romani, principalmente attraverso i siti delle necropoli e degli
oggetti di ornamento personale associati agli individui in esse inumati. Questi
oggetti avrebbero costituito le tracce distintive di un dress-code ben definito
attraverso cui un individuo poteva essere riconosciuto come un “goto”, un
“burgundo”, un “franco” o un “longobardo”. Vi è un’immensa letteratura di
studi classificatori (di origine prevalentemente austro-tedesca), fiorita tra fine
’800 e proseguita sino agli anni ’70 del XX secolo, che documenta gli sforzi
compiuti per riconoscere gli oggetti “diagnostici” del costume di ciascun
popolo e seguirne l’evoluzione estetica nel tempo, fino a quando l’uso di
seppellire i defunti con il corredo non si esaurisce, con tempistiche diverse
all’interno dei vari territori, e nell’ambito di un quadro di progressiva assimilazione
di pratiche funerarie di ascendenza “romana”.
A partire dagli anni ’80, però, questo schema è stato progressivamente messo
sempre più in discussione (in diretta conseguenza dei ragionamenti sulle
fonti scritte prima ricordati), inizialmente soprattutto da studiosi austriaci, che
hanno messo in discussione l’ipotesi che quegli oggetti che vediamo collocati
nelle sepolture costituissero un dress-code stabile nel tempo e riservato ai soli
individui di stirpe “barbarica”, e non anche – magari – a Romani cooptati fra
i membri dell’élite dei conquistatori. Infine, in seguito ad alcuni ritrovamenti
recensioni 353
effettuati a Roma nel sito della Crypta Balbi di oggetti di finimento personale,
datati al VII secolo, e molto simili ad altri recuperati in alcune necropoli
“longobarde” dell’Italia centrale, si è voluto anche smentire che quegli oggetti
fossero almeno prodotti dai Longobardi: se li facevano produrre a Roma, città
in mano ai Bizantini, come possono essere considerati oggetti “etnici” longobardi?
Tutte queste osservazioni hanno colto inizialmente limiti molto evidenti
di una impostazione di stampo tendenzialmente antiquario e ingabbiata all’interno
di un positivismo classificatorio un po’, propria degli studi più tradizionali,
troppo rigido. E si capisce bene, anche in questo caso, la posta in gioco
– in termini di riflessi sul presente – del prevalere di una visione che rendesse
più fluidi i confini fra le identità dei barbari e dei Romani. Quegli omoni alti
e biondi vestiti in modo smaccatamente diverso dai Romani e rispondente
a loro antiche tradizioni, che avrebbero invaso l’Impero Romano prima nel
III e poi, con più successo, nel V secolo, qualcuno avrebbe voluto considerarli
gli antenati di altri individui alti e biondi inviati a conquistare l’Europa alla
fine degli anni ’30 del ’900. In realtà, secondo le più recenti riletture, essi non
sarebbero stati necessariamente tutti barbari (oltre che non essere tutti alti e
biondi), né i loro monili rispecchiavano alcuna tradizione autoctona ed inveterata
dei loro supposti “popoli”, che altro non erano se non agglomerazioni
recenti e provvisorie, formatesi in vista dell’ingresso nei territori imperiali.
Ergo, ogni riferimento a fatti e persone effettivamente esistite, al fine di giustificare,
sui presupposti del passato, ogni egemonia sul presente, sarebbe stato
totalmente fuori luogo.
Tuttavia, tale impostazione “decostruttivista” ha però progressivamente
iniziato ad avvitarsi su se stessa, giungendo talora (già agli inizi di questo secolo)
al paradossale risultato di rendere impossibile lo stabilimento di qualsiasi
criterio di definizione per consentire la riconoscibilità di gruppi di persone
che oggettivamente sono esistite. Le shifting identities dei barbari erano diventate
così tante che non c’erano più parole per denominarle…
Di fronte a questa deriva, si è perciò prodotta – soprattutto nell’ultimo decennio
– una reazione (parola da maneggiare con cura) che ha inteso riportare in
primo piano alcune realtà troppo evidenti per essere negate: innanzitutto quella
secondo cui fra oggetti di corredo personale e appartenenza “etnica” un nesso
c’è ed è innegabile, oltretutto di recente ribadito dai risultati di analisi del DNA
difficilmente contestabili.
Questa discussione ha avuto (e probabilmente ha ancora) anche molto a che
fare con il potere accademico di chi ha sostenuto le diverse posizioni; e i suoi
potenziali addentellati di natura “politica” hanno determinato cautele a volta
eccessive nell’affrontarla in modo aperto.
È forse per questo che, come dicevo in precedenza, solo una figura come
quella di Elena Percivaldi, esterna a tali dinamiche e dotata dell’approccio “cronistico”
del giornalista, poteva riassumerla in modo più completo e distaccato:
ed infatti è stata la prima a farlo, almeno in una pubblicazione destinata ad un
pubblico più ampio di quello degli studiosi. Forse questo aiuterà pure gli appar354
recensioni
tenenti a quest’ultima categoria (magari soprattutto i più giovani) ad iniziare ad
orientarsi meglio all’interno di un ginepraio di posizioni, spesso divise fra loro da
nuances talora anche un po’ capziose.
Peraltro, si legge fra le righe che lei ha una sua convinzione in merito (e
lascerò ai lettori il gusto di scoprire quale sia), ma molto correttamente riporta
tutte le opinioni in campo. E per far questo – ed entriamo quindi a parlare del
secondo merito di questo libro – la Percivaldi utilizza a tutto campo i dati emersi
dall’analisi delle fonti archeologiche5.
Le sintesi che ho citato prima, invece, ad eccezione di quella della Melucco
Vaccaro (che però ormai è molto datata), sono state tutte assai restie ad addentrarsi
nel campo della valutazione dei dati archeologici, il che ne costituisce un
limite oggettivo, ovviamente a prescindere dalla loro qualità scientifica intrinseca,
che è alta in tutti i casi.
Elena Percivaldi, invece, li ha utilizzati a piene mani ed essi le hanno consentito
di costruirvi la narrazione relativa alla parte finale della seconda sezione e
a buona parte della terza sezione del libro (non a caso intitolata “La vita materiale”),
che tratta temi come quelli dell’insediamento (e quindi delle condizioni
di città e campagne), della religione, dei costumi funerari, del modo di vestirsi e
di armarsi, delle abitudini alimentari e della produzione artistica. Ma, va anche
detto, un merito parimenti importante è stato anche quello di aver dedicato tutta
una sezione del libro (la seconda) al “racconto” delle fonti scritte che parlano dei
Longobardi, facendo capire come ciascuna di esse sia orientata e, quindi, quale
visione possa dare dei fatti narrati6. Anche questo è un complemento utile per la
comprensione della vicenda.
Il libro, dicevamo all’inizio, si legge sempre senza fatica, anche – ad esempio
– in parti che trattano argomenti normalmente ostici, come quello dell’organizzazione
dello Stato longobardo, trattata soprattutto nella prima sezione. L’unico
rilievo che sento di poter sollevare a tal proposito è quello relativo alla funzione
dei duces che si erano spartiti il regno al momento della conquista: definire
questi personaggi come dei “funzionari” (p. 40) mi sembra abbastanza riduttivo.
Ammesso che si possa davvero parlare di un “ceto funzionariale” all’interno
del regno longobardo, certamente i duchi non ne facevano parte. Essi erano
piuttosto i capi (militari) dei clan in cui il popolo longobardo era suddiviso
e la loro obbedienza al re era (almeno in linea di principio) volontaria e non
dettata dal tipo di subordinazione che intercorreva fra – ad esempio – l’impe-
5. Fra i tanti temi di storia territoriale che l’Autrice è stata fra i pochi a raccontare con
chiarezza, vi è ad esempio quello relativo alla capitale del regno, che viene abitualmente
identificata ab initio con la città di Pavia, che invece si afferma in questo ruolo solo nel
secondo quarto del VII secolo.
6. Va però rilevato che, quando a pag. 78 dice che la cronaca di Erchemperto costituisce
l’unica fonte narrativa per la Longobardia meridionale nel IX secolo, l’Autrice dimentica che
in realtà c’è anche la Chronica (o Cronicae) Sancti Benedicti Casinensis, prodotta sicuramente
a Montecassino nel terzo quarto del IX secolo, di cui peraltro si è avuta di recente una
bella e facilmente accessibile edizione a cura di Luigi Andrea Berto (Cronicae Sancti Benedicti
Casinensis, Firenze, 2006 [Edizione Nazionale dei Testi Mediolatini, 15]).
recensioni ratore tardoantico e i suoi funzionari, anche quelli più alti in grado. Altrettanto,
sarebbe stato utile spendere qualche parola in più sull’importanza dei rapporti di
fedeltà formalizzati fra i potentiores del regno (re e duchi in primo luogo) e i loro
collaboratori più vicini. Il regno longobardo non ha mai prodotto un sistema
esattamente corrispondente a quello vassallatico-beneficiario emerso progressivamente
nel regno franco fra VII e VIII secolo, ma la presenza della figura del
gasindius in testi giuridici e documentari, ossia di un individuo (libero) preferito
dal re, anche per incarichi di estremo rilievo, perché a lui legato da un rapporto
di esplicita fedeltà personale, ha rappresentato qualcosa da esso concettualmente
non molto dissimile.
Infine, un paio di considerazioni di carattere più generale. È stato certamente
frutto di una scelta da parte dell’Autrice quello di non includere nel suo progetto
editoriale anche il racconto della storia del Meridione longobardo, che
si protrae sin quasi alla fine dell’XI secolo. Un lasso temporale addirittura più
lungo di quello della durata del regno pavese indipendente, in cui la storia del
Mezzogiorno ha sviluppato peculiarità che rendono ancor oggi queste regioni
diverse dal resto dell’Italia. Comprendo le ragioni intuibili per cui questa inclusione
non è stata fatta, ma allo stesso tempo penso che, se la Percivaldi avrà modo
e opportunità di produrre una seconda edizione di questo libro, tale lacuna vada
assolutamente colmata7. Le sue capacità di sintesi sono emerse talmente bene
in questa circostanza, che non credo avrebbe difficoltà ad esercitarle anche per
delineare adeguatamente questo tema.
Altrettanto, una seconda edizione dovrebbe assolutamente dotarsi di un dossier
d’immagini. Se il testo non fosse così ben costruito, la loro assenza – da
imputare certamente a criteri di economia editoriale e quindi non alla volontà
dell’Autrice – si sarebbe sentita ancor di più: ma indubbiamente, quando si parla
di siti, monumenti, oggetti, il non poterli vedere rappresentati da un’immagine
costituisce un po’ un handicap.
In conclusione: Elena Percivaldi ha avuto il coraggio di cimentarsi con il
tema prescelto, assai dibattuto, e il risultato l’ha premiata grazie a un prodotto
che, pur inserendosi in un panorama abbastanza affollato, è riuscito a spiccare
per una sua originalità, soprattutto grazie al fatto di aver descritto in modo piuttosto
completo lo stato dell’arte sulle conoscenze dei primi due secoli di storia
longobarda, quelli del regnum.
I punti critici individuati nel testo (di cui alcuni sono stati qui segnalati) non
ne inficiano la validità complessiva e si spera anzi che possano essere riconsiderati
per una futura nuova edizione di un’opera che potrà certamente contribuire
a rendere l’Alto Medioevo più familiare anche a chi non lo studia per mestiere.
Federico Marazzi
7. Sempre riguardo al Meridione d’Italia, va segnalata come un evidente refuso la data
dell’808 indicata per la fondazione del monastero di San Vincenzo al Volturno (è invece
tradizionalmente considerato in tal senso l’anno 703), così come non ne fu l’abate Epifanio
(in carica fra l’824 e l’842) il primo abate.